
La
Notizia/////////////////////////
///////////////////////di Paolo Pulina
![]()
////////////////////////////
Su Antonio Gramsci un libro postumo di Franco Fergnani
//////////////////////////////
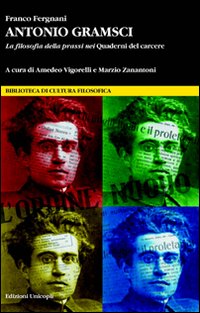 Mi
sono laureato nell’Università Statale di Milano con una tesi
su “La ricezione del pensiero e dell’opera di Antonio Gramsci
in Francia”. Relatore della tesi fu il prof. Franco Fergnani, docente
di Filosofia morale, uno dei pochi professori che agli inizi degli anni
Settanta, nell’Università milanese, si occupavano di Gramsci
“filosofo” sull’onda degli studi che in materia erano
stati pubblicati in Francia.
Mi
sono laureato nell’Università Statale di Milano con una tesi
su “La ricezione del pensiero e dell’opera di Antonio Gramsci
in Francia”. Relatore della tesi fu il prof. Franco Fergnani, docente
di Filosofia morale, uno dei pochi professori che agli inizi degli anni
Settanta, nell’Università milanese, si occupavano di Gramsci
“filosofo” sull’onda degli studi che in materia erano
stati pubblicati in Francia.
È da dire infatti che, sia nel corso degli anni 1968 e 1969 –
cioè nel biennio delle più vigorose battaglie studentesche
e operaie –, sia nei primi anni Settanta, la figura e l’opera
di Gramsci occupavano una dimensione indubbiamente marginale nel quadro
dei riferimenti ideologici di quei movimenti di massa, di quelle “masse
popolari” (peraltro gli stessi che usavano questa espressione, “masse
popolari”, per intendere un superamento-ampliamento del concetto
rigorosamente marxiano di proletariato, pensavano che avesse una derivazione
da Stalin non dalla concezione – antistalinistica, storicamente
e ideologicamente – di Gramsci!).
Nello specifico, nell’ambito del movimento studentesco della Statale,
l’ala non stalinista “Gruppo Gramsci”, guidato da Pasquale
(Popi ) Saracino, era sicuramente minoritaria.
Per la verità c’era un altro filosofo, docente di Filosofia
teoretica, che nella stessa Università dimostrava interesse alle
posizioni “filosofiche” di Gramsci: mi riferisco a Enzo Paci,
che aveva citato Gramsci nella prefazione alla traduzione italiana dell’importante
volume di Edmund Husserl “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale: introduzione alla filosofia fenomenologica” (a cura
di W. Biemel; avvertenza e prefazione di Enzo Paci; trad. di Enrico Filippini,
Il Saggiatore, 1972), e che del pensiero di Gramsci si occupava nelle
lezioni su “La crisi delle scienze europee di Edmund Husserl”
(si vedano gli appunti dalle lezioni del prof. Enzo Paci; a cura di F.
Mucciarelli, Milano, Cuem, 1973).
In generale, però, in Italia non si registrarono nella seconda
metà degli anni Sessanta e negli anni Settanta dibattiti su Gramsci
“filosofo” (anni 1965-1968) e su Gramsci politico (1969-1975)
paragonabili a quelli che ebbero luogo in Francia in questi due archi
temporali.
Nel campo della riflessione filosofica basta citare i due testi di Louis
Althusser Per Marx (1965; traduzione italiana 1974) e Leggere “Il
Capitale”, (1965; traduzione italiana 1976), che per così
dire “fondano” quella ricerca teo¬rica marxista di cui
lo stesso Althusser, nella prefazione a Per Marx, aveva lamentato la “tenace
assenza” in Francia. Al di là delle critiche allo “storicismo
assoluto” gramsciano, Althusser riconosce la “genialità”
di Gramsci nell’analisi delle sovrastrutture (gli apparati ideologici,
politici, culturali, ideali, morali che possono assicurare l’egemonia
nella vita della società e che sono altrettanto importanti che
la “struttura” economica di base). Gramsci viene ad essere
considerato (anche da uno che si chiamava François Mitterrand)
come il dirigente politico e teorico della politica che ha elaborato la
strategia della pacifica rivoluzione socialista in Occidente. Nel campo
della teorizzazione politica, dopo il maggio 1968, Roger Garaudy, membro
del Comitato Centrale e del¬l'Ufficio Politico del Partito Comunista
Francese , in tema di alleanze della classe operaia, propose l'organizzazione
di un nuovo “blocco storico”, concetto di palese origine gram¬sciana.
(Nota d’obbligo: oggi non posso che pronunciare con nausea il nome
di Roger Garaudy, dato che addirittura è passato al fronte dei
“negazionisti”, cioè di coloro che negano che siano
esistiti i campi di sterminio nazisti e le camere a gas…).
Fergnani tenne il suo corso su “La filosofia della prassi nei Quaderni
del carcere di Gramsci” nell’anno accademico 1975-1976. La
spinta decisiva per quel ciclo di lezioni fu sicuramente data dalla prima
edizione critica dei Quaderni gramsciani, a cura di Valentino Gerratana
(Einaudi, 1975).
In cinque densi capitoli Fergnani illustra e discute l’analisi di
Gramsci riguardo a concetti quali “ideologia”, “blocco
storico”, “concezione soggettivistica della realtà”,
“prassi e tecno-prassi” “la dialettica nella storia”.
Queste lezioni di Fergnani furono pubblicate dalla Cuem nel 1976 e sono
state riprese recentemente, a cura di due suoi “antichi” allievi,
Amedeo Vigorelli e Marzio Zanantoni, per le Edizioni Unicopli di Milano
(pagine 90). Nella premessa i curatori scrivono: “I Quaderni sono
fatti liberamente dialogare con le posizioni del marxismo occidentale,
al di fuori di qualsiasi preoccupazione di ortodossia (sia nella versione
storicistica di Palmiro Togliatti sia nella versione antistoricistica
di Galvano della Volpe). Ai Quaderni gramsciani Fergnani si rivolgeva
come ad un classico della letteratura filosofica europea di cui era recente
la riscoperta (in particolare in Francia)”.
Fergnani, nato a Milano il 25 ottobre 1927, era figlio di Elda Magnoni
e dell' avvocato Enea, antifascista (questi fu preso dalle SS, portato
a San Vittore, poi nel campo di transito a Fossoli, destinazione Mauthausen,
da cui riuscì miracolosamente a salvarsi). Franco aderì
giovanissimo alla lotta partigiana. Nel dopoguerra, terminati gli studi
si laureò nel 1953, allievo di Antonio Banfi, con una tesi sul
marxismo. Iniziò la carriera universitaria in Statale come assistente
volontario fino a diventare professore di Filosofia morale.
Ha scritto in suo ricordo Franco Manzoni (“Corriere della Sera”
del 19 gennaio 2010): “Fergnani, uomo riservato di straordinaria
cultura e sensibilità, tutto immerso nel suo mondo di studi e letture,
fuori dagli schemi, indimenticabile per tutti gli studenti che hanno seguito
le affollatissime lezioni su Marx, Pascal, Montaigne, Heidegger, Jaspers.
E soprattutto Sartre, di cui era considerato uno dei più profondi
esegeti. Condusse sempre una vita molto appartata, mostrando disinteresse
verso denaro, profitto, fama. Sempre disponibile verso gli allievi e i
suoi collaboratori più stretti, lasciò l' insegnamento nel
2000 e si dedicò fino all' ultimo allo studio dell’opera
di Sartre”.
Nota finale. Questo mio scritto vuole essere un omaggio riverente alla
memoria del “mio” prof. Fergnani a 85 anni dalla nascita e
un invito a leggere queste sue lezioni su Gramsci. La mia tesi sulla ricezione
di Gramsci in Francia nacque naturalmente, sulla base di un interesse
non epidermico per le teorizzazioni filosofiche e politiche del Grande
Corregionale Sardo, per il desiderio di studiare le motivazioni che Oltralpe
le avevano portato al “successo”, addirittura al dibattito
politico corrente. Da sardo, all’inizio del 2012, ricordo inoltre
che il 22 gennaio ricorre il 121° anniversario della nascita di Gramsci
(Ales, 22 gennaio 1891), e il 27 aprile il 75° anniversario della
sua morte come martire antifascista (Roma, 27 aprile 1937).
(13-01-2012)